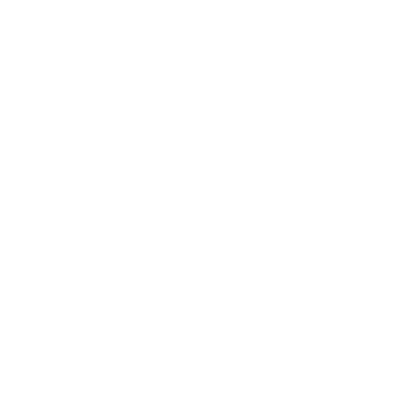LA FORMAZIONE TEOLOGICA TRA CONOSCENZA, SAPIENZA E DISCERNIMENTO
Inaugurazione del XXVII Anno Accademico del Camillianum
Mercoledì 19 novembre 2014, è stata celebrata l’inaugurazione dell’Anno Accademico del Camillianum (Istituto internazionale di teologia pastorale sanitaria) a Roma.
Leocir Pessini, Superiore generale dell’Ordine dei Ministri degli Infermi e Moderatore generale del Camillianum, nell’omelia della celebrazione eucaristica ha ricordato che il germe della vera formazione umana e teologica consiste nella  capacità di far interagire conoscenza (dato culturale), sapienza (apporto esistenziale) e discernimento (capacità progressiva di distinguere nella storia quotidiana ciò che eleva e promuove l’uomo da ciò che lo degrada).
capacità di far interagire conoscenza (dato culturale), sapienza (apporto esistenziale) e discernimento (capacità progressiva di distinguere nella storia quotidiana ciò che eleva e promuove l’uomo da ciò che lo degrada).
Questi sono i prerequisiti umani ed intellettuali per poter aprire le finestre allo Spirito, apportatore di permanente bellezza, verità e nuova bontà, riparatore di ferite e tensioni, ripresentatore in noi della splendida umanità del Figlio di Dio, fonte permanente di ispirazione e di crescita anche per la nostra umanità, che sull’esempio di San Camillo siamo chiamati a sviluppare e a vivere nella forma di un cuore che continua a pulsare nella concretezza delle opere delle nostre mani.
Pessini introduce l’atto accademico assembleare ringraziando la presidenza, la segreteria e il corpo docente del Camillianum, per il prezioso apporto che l’Istituto offre nell’ambito della formazione di religiosi, religiose e laici che opereranno a livello pastorale nel mondo della salute e della malattia.
Rilancia il progetto di ri-editare, in modo aggiornato, il Dizionario di Teologia Pastorale, essendo un prezioso strumento per coloro che vogliono implementare la loro formazione umana e teologica.
Propone anche l’idea di una comunità accademica al Camillianum, attraverso una maggiore sinergia con altri centri universitari, a cominciare da quello dell’Università Camilliana di San Paolo del Brasile.
Segnala, con commozione, la recente pubblicazione della tesi di dottorato di p. Francisco Alvarez, religioso camilliano – attualmente molto malato – tra i fondatori del Camillianum e per lunghi anni docente nel medesimo Istituto.
Mons. Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense – a cui il Camillianum è incorporato – ha proposto la sua lectio magistralis articolata sul tema “I primi cristiani e la medicina, l’assistenza e la cura dei malati”.
Nei primi secoli cristiani, rispetto alla medicina laica, viene proposta l’immagine di Cristo “medico e medicina”, terapeuta del corpo e dell’anima (“Cristo farmaco dell’immortalità” – soprattutto nei padri orientali) in continuità con i miracoli di guarigione dei Vangeli, in cui Cristo appare come l’unico autore della guarigione e della salvezza dell’uomo.
San Giovanni Crisostomo raffronta i sacerdoti e i medici: è un confronto che poi diventerà classico! Come il medico cura il corpo dell’uomo, così i sacerdoti con la loro parola e la loro testimonianza sollevano e guariscono lo spirito umano.
Tale proposta cristiana, si collocava sulla linea del contrasto del dualismo gnostico (spirito vs. carne) che disprezza il corpo, la carne e come tale anche la medicina che curava l’equilibrio della biologia dell’uomo. Anche una certa mistica cristiana, sostenitrice di un’eccessiva pedagogia del dolore umana, andava ricondotta ad un sano equilibrio.
È rimasta poi latente anche nelle comunità cristiane dei primi tre secoli, la pratica della magia a fini terapeutici e di guarigioni (cfr. la pratica degli amuleti, dell’incubazione dei malati nei luoghi sacri del paganesimo). Al culto di Asclepio, i cristiani oppongono il culto di santi taumaturghi, anargiri, … i confini tra medicina religiosa, magica e laica diventano sempre più sfumati. Tuttavia nella grande chiesa –nei primi tre secoli del cristianesimo – il rapporto attestativo di reciprocità tra cristianesimo e medicina sembra mantenersi solido e fruttuoso.
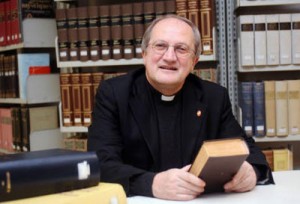
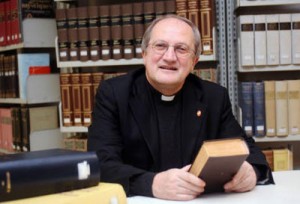
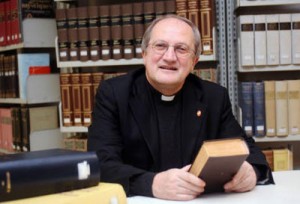
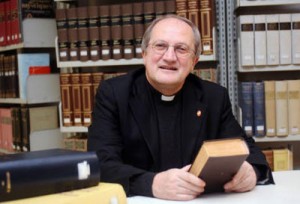
In Oriente, i grandi flussi migratori dopo la svolta costantiniana (313 d.C.), i grandi movimenti dei pellegrini in Terra Santa, i commerci lungo le grandi vie di comunicazione avevano determinato la presenza di grandi masse di uomini e donne esposte ad ogni genere di bisogni e di necessità, anche di natura sanitaria. Nascono quindi dei luoghi deputati all’accoglienza e alla cura di questi bisogni. L’ospedale è nel IV secolo una delle grandi intuizioni delle comunità cristiane soprattutto in Oriente. Si istituiscono alloggi per pellegrini e viandanti, i ricoveri per poveri e malati cronici, i lebbrosari, i gero-comi, i noso-comi. I fondatori di questi istituti sono imperatori ed imperatrici, ecclesiastici, laici filantropi, …
Basilio vescovo di Cesarea costruisce la Basiliade, la città dei malati e dei poveri. Essa sarà all’origine di altre forme più strutturate di assistenza e di cura.
Lavoravano negli ospedali quei monaci che si sentivano attratti da una forma più pratica della loro vocazione monastica (maggiore sinergia tra mistica/preghiera/contemplazione ed esercizio fattivo della carità): l’associazione tra cenobio ed ospedale continuerà a lungo nell’oriente bizantino. Nei primi secoli cristiani la stretta connessione tra comunità cristiane e nosocomi nasce, cresce e si sviluppa soprattutto in Oriente.
Non mancano esempi di cura e di assistenza anche in Occidente: tuttavia sono frutto di iniziative personali di singoli credenti e di uomini e donne di chiesa (cfr. l’attività di Paolino da Nola). In occidente gli ospedali mantengono ancora in profilo di luoghi generici di accoglienza dei poveri e dei pellegrini. Solo in seguito assumeranno anche il profilo della cura più specificamente di natura sanitaria.
Resta un dato di fondo: la cura e l’assistenza sanitaria in quest’epoca crescono in sintonia con la crescita della dimensione della carità delle comunità cristiane (rapporto inscindibile tra l’amore di Dio e l’amore del prossimo, soprattutto quello più fragile e malato).
Per chi desidera continuare la riflessione offriamo il testo della lectio magistralis di S.Ecc. Mons. Enrico dal Covolo, Magnifico Rettore della Pontificia Università Lateranense
Salva
Salva